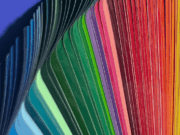Il Vietnam dice addio al generale Giap.
Sono iniziati oggi ad Hanoi i funerali di Stato per l’eroe dell’indipendenza e delle guerre contro i francesi e gli americani, morto una settimana fa all’età di 102 anni.
Le esequie del comandante Vo Nguyen Giap si concluderanno domenica con la sepoltura della salma nella sua città natale, Yen Island.
Ad Hanoi, nel febbraio del 1969, il generale Giap concesse un’intervista a Oriana Fallaci, allora reporter de L’Europeo, non perdonandole mai di aver pubblicato il contenuto integrale di quel colloquio; ripreso poi anche nella raccolta Intervista con la storia, edita da Rizzoli nel 1974. Fu la stessa giornalista fiorentina a raccontare come andarono le cose, nel preambolo all’intervista che abbiamo deciso di riportare.
Chi era il generale Giap?
Era l’uomo il cui nome veniva pronunciato più spesso durante la guerra in Vietnam. E non perché fosse il ministro della Difesa a Hanoi, il comandante in capo delle Forze armate, il vice primo ministro, ma perché era colui che aveva sconfitto i francesi a Dien Bien Phu. Gli americani vivevan nell’incubo di una nuova Dien Bien Phu e, appena le cose andavano peggio, si diceva: «È Giap che prepara una nuova Dien Bien Phu». Oppure, semplicemente: «È Giap». S’era detto Giap nel febbraio del 1968, quando i vietcong aveva scatenato l’offensiva del Tet. S’era detto Giap nel marzo e nell’aprile quando i nordvietnamiti avevan tenuto Hué e assediato Khe San. S’era detto Giap nel maggio e nel giugno quando i vietcong avevano lanciato la Seconda offensiva a Saigon e sulle Pianure centrali. Si sarebbe detto Giap anche dopo, per anni. Quel nome breve e secco come uno schiaffo era una minaccia sempre sospesa nell’aria, uno spauracchio dal diciassettesimo parallelo in giù. I bambini li spaventi sussurrando «Ora chiamo l’orco». Gli americani li spaventi sussurrando «Ora viene Giap». Del resto non lo avevano gonfiato essi stessi, con la loro mania della leggenda? Non s’erano nemmeno chiesti se la leggenda fosse prematura. […] Ma Giap restava Giap. E chiunque fosse un giornalista voleva intervistare Giap. […] Giap aveva un mucchio di cose da dire, e non le diceva dal 1954. Più inavvicinabile dello stesso Ho Ci-min, non si mostrava nemmeno alle cerimonie ufficiali: ogni tanto si spargeva la voce che fosse morto. Così, appena giunta ad Hanoi in quel febbraio del 1969, avevo chiesto di vedere Giap e m’ero preparata con ostinata speranza all’incontro: documentandomi con cura sulla sua biografia. Una storia talmente affascinante la storia di questo Giap che, figlio di un proprietario terriero caduto in miseria, era cresciuto in una famiglia di ricchi francesi: ben lontano da una educazione marxista. Da buon borghese aveva studiato al collegio imperiale di Hué, poi all’università di Hanoi, qui s’era laureato in giurisprudenza e in filosofia; infine aveva fatto l’insegnante di lettere e storia al liceo francese di Hanoi ossessionando i suoi allievi con le campagne di Napoleone. Disegnava sulla lavagna i particolari delle battaglie, le analizzava con prolissità, e i colleghi lo prendevano in giro: «Vuoi diventar generale?». Come rivoluzionario però aveva cominciato assai presto: a quattordici anni. A diciotto, del resto, era già stato in prigione, a venti s’era messo con Ho Ci-min che per le sue collere ciclopiche e i suoi silenzi di marmo lo chiamava Vulcano Coperto di Neve, per il suo coraggio lo chiamava Kui, Diavolo… Nel 1935 era entrato nel partito comunista e s’era sposato con una compagna: Minh Tai. Nel 1939, l’anno in cui i comunisti eran stati messi fuori legge, era scappato in Cina e Minh Tai aveva coperto la fuga facendosi arrestare al suo posto. Per questo era morta, nel 1941, dentro una cella infestata di topi… Molti sostenevano che in seguito a ciò Giap avesse imparato a odiare: chiuso ad ogni pietà, aperto ad ogni crudeltà. Non lo sapevano i francesi che, tra il 1945 e il 1954, eran caduti nei suoi trabocchetti pieni di api velenose, nelle sue buche piene di serpenti, o eran saltati sulle mine nascoste sotto i cadaveri abbandonati per strada? Maestro del sabotaggio, usava dire che la guerriglia avrebbe sempre avuto ragione delle armi moderne. […] Alla sua durezza non era estraneo il cinismo ed infatti aveva poco in comune con gli austeri marxisti di Hanoi. […] A Hanoi la mia richiesta di intervistare Giap era stata accolta con molte riserve dai nordvietnaminiti: «Perché proprio Giap? La guerra non la fa solo Giap. E poi Giap non riceve». Ma, tre giorni prima della partenza, la mia accompagnatrice An The mi regalò la notizia che sì, avrei visto Giap […].
Mi stupì anzitutto la sua piccolezza. Sapevo che non raggiungeva il metro e cinquantaquattro ma, visto così, sembrava ancora più corto. […] Gli occhi eran gli occhi più intelligenti, forse, che avessi mai visto. Acuti, astuti, ridenti, crudeli: tutto. Brillavano quanto due gocce di luce, bucavano quanto due coltelli affilati, e trasmettevano una tal sicurezza. Una tale autorità. […] Mi venne incontro con la mano tesa in una disinvoltura mondana. Anche il suo sorriso aveva un che di mondano. […] Accadde che Giap vide il mio magnetofono e si allarmò. […] Io cercai di contrattare, ne nacque una discussione alla fine della quale ci accordammo sulla necessità di prendere almeno gli appunti. E, sulla scia di questo discorso, cominciai a farlo parlare.
Non fu nemmeno difficile: è il caso di confessarlo. Giap adora parlare e parlò per quarantacinque minuti, senza chetarsi mai, col tono cattedratico del professore che insegna ad alunni poco intelligenti. […] La sola che non scriveva ero io ma come avrei potuto mentre i suoi terribili occhi mi cercavano gli occhi? Giap mi interrogava a sua volta, mi rimproverava, mi contestava, e non era raro che si abbandonasse a esplosioni di passionalità. Come quando gli dissi che l’offensiva del Tet era fallita, e lui si alzò nervosamente, girò intorno al tavolo, allargò le braccia, con le braccia spalancate esclamò: «Questo lo dica al Fronte di liberazione». (Così sconfessando ogni sua responsabilità nell’offensiva che tutti gli attribuivano.) Le sue manine si agitavano senza sosta, v’era in lui il compiacimento di chi ama ascoltarsi, e si chetò soltanto quando capì che l’ora stabilita era superata.
[…] In albergo trascrivemmo parola per parola gli appunti […], poi li confrontammo e componemmo il testo dell’intervista: non rinunciando nemmeno a una virgola. Ma il mattino seguente mi riserbò una sorpresa. Venne An The, con tre foglietti di cartavelina scritti a macchina, e me li consegnò dicendo che questo, solo questo, era il testo del colloquio che avevo avuto col generale. Il generale non avrebbe riconosciuto altro testo e io dovevo impegnarmi a pubblicarlo. Lessi i foglietti. Non c’era più nulla di ciò che avevo ascoltato e che gli altri avevan trascritto. […] Non c’era nulla fuorché una serie di frasi retoriche e vaghe: buone tutt’al più per un comizio. […] «Lo pubblicherò» risposi. «Ma insieme al testo vero.» E lo feci.
Giap non me lo perdonò mai e i nordvietnamiti che mi avevano dato il visto ancor meno. L’indipendenza di giudizio, si sa, è una virtù che a molti comunisti non piace. O gli piace solo nei casi in cui ti induce a scrivere ciò che fa comodo a loro.
Foto: generale Vo Nguyen Giap, via Wikimedia